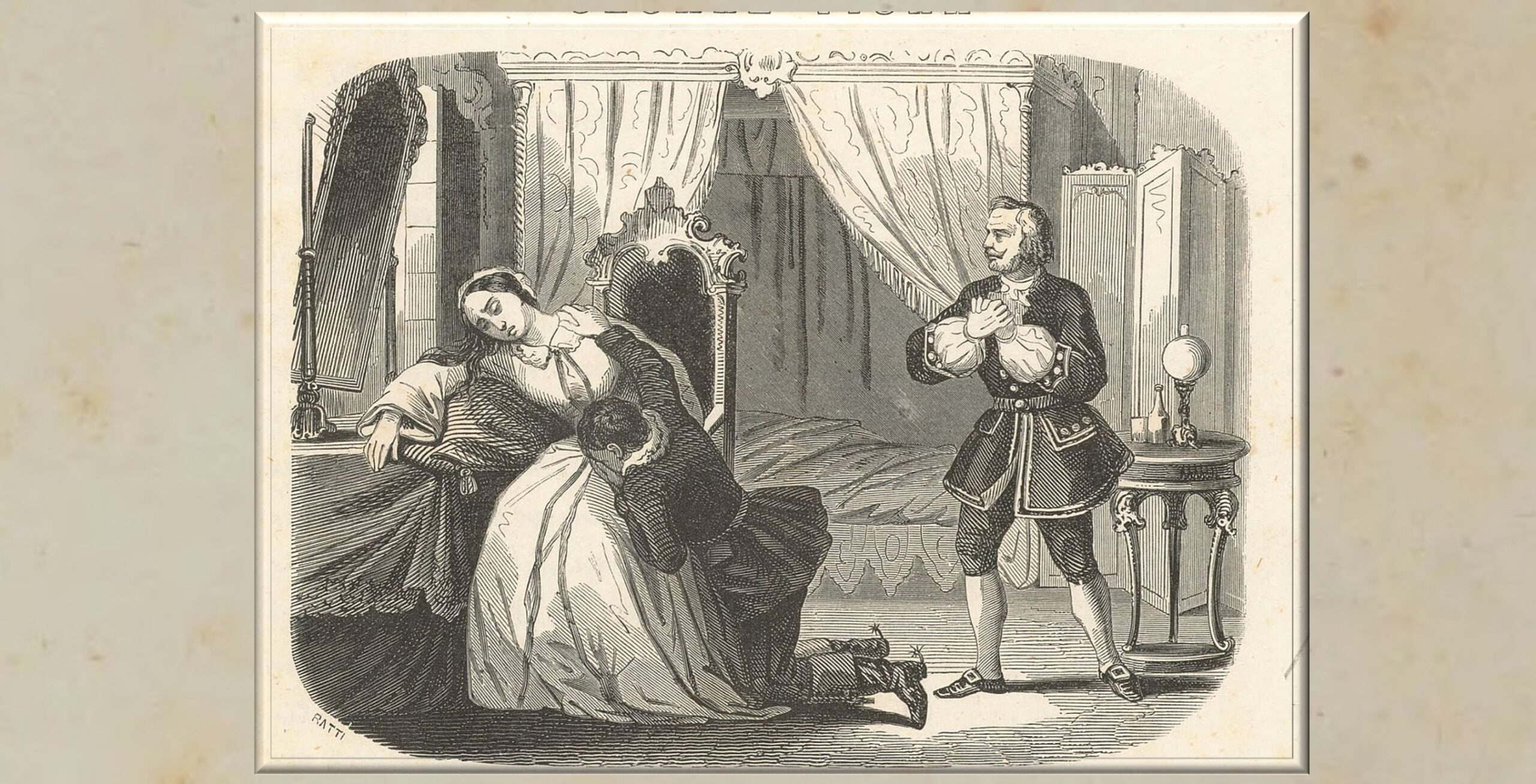Paura della morte e amore per la vita: Edith Stein e l’incontro col morente
Stephan Kampowski
Image by James Chan from Pixabay

Prefazione a GUIDO MICCINESI, Ti sarò vicino. Sulle tracce di Edith Stein: empatia e incontro col morente, Ti sarò vicino. Sulle tracce di Edith Stein: empatia e incontro col morente, Edizioni Messaggero Padova, Padova 2021, 9-19.
Perché chiamare in causa Edith Stein quando si discute della cura dei morenti?
Una prima risposta lampante è che la Stein ha scritto un’opera seminale sull’empatia, e l’empatia ha un ruolo importante quando si accompagnano i malati terminali. Una seconda risposta, meno scontata, è che ha composto un brano illuminante di critica a Essere e tempo di Martin Heidegger, in cui, tra le altre cose, contesta il suo resoconto filosofico della morte[1].
1. Essere-per-la-morte? L’angoscia davanti al nulla
Cominciamo con una breve discussione sulla seconda risposta. Nel presente libretto[2] Guido Miccinesi sostiene che oggi alcuni elementi centrali dell’esistenzialismo di Heidegger, sebbene in modo non ponderato, abbiano effettivamente iniziato a esercitare un’ampia influenza su come le persone oggi comunemente pensano. Come è possibile, per esempio, che in tempi recenti le richieste di eutanasia siano espresse sempre più di frequente da pazienti sottoposti a cure palliative, e dunque affetti da un dolore fisico sotto controllo, quando lo scopo iniziale dello sviluppo delle cure palliative era di presentare un’alternativa alla tentazione dell’eutanasia? Che cosa c’è alla base di una richiesta di eutanasia o di suicidio assistito se tale domanda non è motivata dal dolore fisico? O come è possibile, potremmo aggiungere noi, che un’organizzazione svizzera che fornisce assistenza al suicidio scelga di chiamarsi Dignitas (“dignità”)?
Alla radice di questi fenomeni sembrerebbe sottesa una certa visione della vita e della morte, che possiamo trovare espressa in qualche misura nel pensiero di Martin Heidegger (e nel pensiero esistenzialista in generale). Per il filosofo tedesco l’Esserci, l’esistenza umana, diventa autentico nel suo confronto con la morte. Il nostro essere è essere-per-la-morte. Di fronte alla morte usciamo dal modo di essere che egli chiama il “Sì”, l’esistenza quotidiana e superficiale. La morte ci isola radicalmente e provoca un’angoscia esistenziale davanti al grande vuoto del nulla. Qui, allora, è necessaria una decisione risoluta su noi stessi, che ci permetta di raggiungere la nostra autenticità o il nostro vero essere.
Scaricare il pdf della prefazione
Per Heidegger stesso, a dire il vero, l’essere-per-la-morte, la risolutezza e l’autenticità non equivalgono ad approvare il suicidio, che egli considera un atto di disperazione che cancella l’Esserci[3]. In una critica pungente al suo professore di un tempo, Günther Stern Anders ribadisce invece che dall’approccio di Heidegger consegue che l’Esserci e il suicidio siano collegati nel modo più intimo:
“[Il ‘Sé’ di Heidegger = l’Esserci] presenta la vita stessa come una sorta di suicidio. Facendosi volontariamente e incessantemente carico della sua morte, l’‘esistenza’ di Heidegger commette un suicidio per tutta la vita”[4].
Questa conclusione, derivi o meno con stretta necessità dalle premesse di Heidegger, ha senza dubbio una certa plausibilità: se arriviamo al nostro vero “sé” solo quando affrontiamo la morte da soli, scegliendo risolutamente noi stessi di fronte al vuoto del nulla, allora niente ci impedisce di vedere la morte per suicidio come la massima affermazione della nostra autonomia e autodeterminazione e quindi la massima espressione della nostra dignità, almeno di fronte alla malattia debilitante e terminale, se non proprio in generale.
2. Interpretare la morte alla luce della vita
Secondo Miccinesi, per rispondere a questa sfida, il contributo di Edith Stein è di enorme aiuto nella misura in cui ci permette di formulare e comprendere meglio ciò che veramente temiamo quando abbiamo paura di morire. Secondo la posizione esistenzialista, noi sperimentiamo un’angoscia esistenziale, una paura di fronte alla morte perché abbiamo timore del non essere, dell’isolamento, dell’insignificanza. Nella sua esperienza personale, in particolare mentre accompagnava i morenti quando lavorava come infermiera durante la Grande Guerra, la Stein ha fatto un’osservazione diversa. La morte è dapprima conosciuta intersoggettivamente. È un fatto evidente che noi sperimentiamo la morte degli altri prima di sperimentare la nostra stessa morte. Leggendo Stein, Miccinesi introduce poi l’importante distinzione tra “l’angoscia elicitata di fronte al morire, cioè di fronte al nulla, e l’angoscia per il morire, per il dispiacere di perdere la vita”[5]. Conclude con una profonda intuizione: “C’è quindi un elemento di amore e apprezzamento della vita nella sofferenza per la morte”[6]. Qui vorrei richiamare quelle che sembrano essere state le ultime parole pronunciate da Charles Péguy mentre combatteva nella prima battaglia della Marna all’inizio della Prima Guerra Mondiale e una pallottola lo colpì alla testa. I suoi commilitoni riferiscono che esclamò: “Oh mio Dio, i miei figli!”[7]. In questi ultimi secondi della sua esistenza terrena, non c’era traccia in lui della paura del nulla, ma un puro dolore nel riconoscere di dover lasciare la sua vita insieme a coloro che amava e di cui era responsabile.
Mentre Martin Heidegger interpreta la vita alla luce della morte, Edith Stein interpreta la morte alla luce della vita, una vita che si ama perché ci sono persone amate, che ora si perdono. Miccinesi spiega come Edith Stein insista “sulla dimensione comunitaria della perdita, sull’empatia da riservare sia per chi soffre per la morte di un altro che per il morente stesso che soffre, dolori spirituali diversi ma accomunati da una stessa perdita di amore”[8]. Il dolore della morte è un dolore di perdita, non solo per chi rimane indietro, ma anche per chi muore. In quello che ritengo essere uno dei contributi centrali del presente libretto, il suo autore conclude: “Mettere a fuoco l’importanza dell’amore nella morte e nel morire si rivela oggi una acquisizione fondamentale per l’accompagnamento del morente” [9].
3. Una nuova luce per la questione dell’empatia
Se è vero che la ragione primaria per cui temiamo la morte è perché amiamo la vita – e non perché siamo in preda all’angoscia davanti al vuoto, o perché siamo isolati, o perché detestiamo subire passivamente qualcosa che non abbiamo scelto autonomamente –, allora la questione dell’empatia con i morenti riceverà una luce nuova e decisiva. L’autore sostiene che l’empatia è una virtù e la definisce, seguendo Stein, come la capacità di “sentire l’altro, dal di dentro”[10]. Non è semplicemente una passione, un tratto del carattere, o una parte della nostra composizione neurochimica, che renderebbe la sua presenza o assenza una questione di destino personale o di fortuna. Piuttosto, come virtù può essere praticata e coltivata. Agendo secondo questa virtù si riesce a rendere presente a se stessi l’esperienza interiore dell’altro, come la sua gioia o il suo dolore.
L’empatia non è né compassione né consolazione, anche se essa è necessaria per guidare entrambe. La compassione da sola può portare a esiti nefasti. Si riferisce al modo in cui io mi sento di fronte all’infortunio di un altro. Ma per capire veramente come si senta l’altro, per rendere presente a me stesso il suo dolore e rispondere adeguatamente ad esso, devo essere capace di mettermi nei suoi panni, cercando di assumere la sua prospettiva. La compassione può anche portare qualcuno al punto di voler uccidere un altro. L’empatia invece non lo farebbe mai.
L’empatia ci permette di essere vicini all’altro. Nel caso dell’accompagnamento dei morenti, ci permette di capire la loro lotta mentre si dibattono tra la speranza e la disperazione. L’empatia, sostiene Miccinesi, richiede la verità “a partire da una corretta posizione di fronte alla morte e al morire” [11]. L’empatia ci permette di leggere secondo la verità la lotta dell’altro con la morte, e solo così possiamo accompagnarlo in modo da essergli realmente di aiuto. Secondo l’autore, una lettura empatica della lotta vissuta da chi sta morendo e delle sue richieste pronunciate in quella fase rivela una preoccupazione predominante: “Dimmi che ti manco!”[12]. Non a caso proprio questa frase dà il titolo a una sezione importante del presente libro, mentre la risposta “Ti sarò vicino” costituisce il titolo principale. Secondo l’autore, anche “la domanda eutanasica è suscettibile di lettura profonda”[13], cioè di una lettura empatica, rivelandosi come la richiesta del paziente di essere confermato e di essere curato. “La domanda eutanasica è ancora una domanda di cura, ma deformata, divenuta cioè contraddittoria e irricevibile”[14]. È una domanda con cui il morente chiede: ‘Dimmi che ti mancherò, che sono importante per te, che è bene che io esista’.
Il presente libretto ci incoraggia a interpretare la nostra paura per la morte alla luce del nostro amore per la vita. E noi amiamo la vita nella misura in cui in essa ci sono persone che amiamo e in quanto ci sappiamo amati. La principale preoccupazione dei morenti, quindi, non risulta essere così diversa dalla principale preoccupazione dei vivi, anche se a quel punto sarà molto intensificata. In effetti, sembrerebbe esserci una stretta corrispondenza tra il nostro modo di vivere e il nostro modo di morire. Vogliamo amare ed essere amati. L’accompagnamento veramente empatico del morente procederà tenendo presente questo bisogno fondamentale, cercando il più possibile di riunire i membri della famiglia intorno al letto di morte, anche se sono dispersi e lontani, fornendo così un’occasione impareggiabile per la riconciliazione. E in un’epoca nella quale la famiglia si sta frammentando anche il personale sanitario avrà un ruolo sempre maggiore nel comunicare al morente: ‘Tu sei importante per me! Mi mancherai!’.
4. Perdita e gratitudine
Infine, possiamo aggiungere qui, se ciò che è veramente in gioco nella paura della morte è l’amore per la vita intimamente connesso al dolore per la perdita, allora assume un’importanza decisiva la comprensione del semplice fatto che, perché qualcosa sia tolta, è necessario che prima sia stata data. Le riflessioni indirizzate da Hannah Arendt alla sua amica Mary McCarthy in occasione della scomparsa di un amico comune possono anche dare orientamenti ai morenti e a quelli che li accompagnano nell’affrontare la perdita finale:
“Guarda, Mary, credo di sapere quanto sei triste e com’è grave questa perdita. […] Eppure – se tu sai solo dire “odioso”, dovrai dirlo di molte altre cose, volendo essere coerente. Si può guardare a tutta la propria vita come cosa-data e cosa-tolta; a cominciare della stessa vita, data alla nascita, tolta dalla morte, e sarebbe facile vedere tutto il periodo intermedio come sottoposto alla medesima legge. […] Ho riguardato le preghiere ebraiche per i morti; queste, cioè il kaddish, sono unicamente una lode del Signore, il nome del defunto non viene nemmeno pronunciato. Il concetto di base è quello che trovi in tutte le pompe funebri ebraiche. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il Signore. Ossia: non lamentarti se ti viene tolto qualcosa che ti era stato dato, ma che non necessariamente ti apparteneva. E ricordati, perché venga tolto bisogna, prima, che venga dato. E peggio per te, se hai creduto che fosse tuo, se hai dimenticato che ti era stato dato.”[15]
Per la Arendt, e sembra a ragione, tale ricordo della gratuità della vita ha un significato cruciale nell’affrontare la morte, ecco perché in un’altra occasione conclude: “Ciò che finalmente acquieta la paura della morte non è la speranza, né il desiderio, ma il ricordo e la gratitudine”[16].
-
E. Stein, “La filosofia esistenziale di Martin Heidegger”, in Id., La ricerca della verità. Dalla fenomenologia alla filosofia cristiana, a cura di A. Ales Bello, Città Nuova, Roma 1993, 153-226. ↑
-
G. Miccinesi, Ti sarò vicino. Sulle tracce di Edith Stein: empatia e incontro col morente, prefazione di S. Kampowski, Edizioni Messaggero Padova, Padova 2021. ↑
-
Cfr. M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano 1976, 280. ↑
-
G. Stern (Anders), “On the Pseudo-Concreteness of Heidegger’s Philosophy”, in Philosophy and Phenomenological Research 8 (1948), 337-371, qui 355. Corsivo nell’originale, traduzione propria. ↑
-
Miccinesi, Ti sarò vicino, cit. 59. ↑
-
Ibid., 59-60. ↑
-
Cfr. J. McCarthy, “Notes on Fatherhood”, in Anthropotes 35 (2019), 149-176, qui 170. ↑
-
Miccinesi, Ti sarò vicino, cit. 63. ↑
-
Ibid., 63-64. ↑
-
Ibid., 76. ↑
-
Ibid, 116. ↑
-
Ibid. 121. ↑
-
Ibid. 122. ↑
-
Ibid. ↑
-
H. Arendt – M. McCarthy, Tra amiche. La corrispondenza tra Hannah Arendt e Mary McCarthy, 1949-1975, a cura di C. Brightman, Sellerio Editore, Palermo 1999, 535-536 (lettera di Hannah Arendt a Mary McCarthy del 25 gennaio 1972). ↑
-
H. Arendt, Love and Saint Augustine, University of Chicago Press, Chicago 1996, 52 (traduzione propria). Su questo tema si veda anche: S. Kampowski, Contingenza creaturale e gratitudine, Cantagalli, Siena 2010. ↑
Condividi questo articolo
Chi siamo
Il Veritas Amoris Project mette al centro la verità dell’amore come chiave di comprensione del mistero di Dio, dell’uomo e del mondo e come approccio pastorale integrale e fecondo.