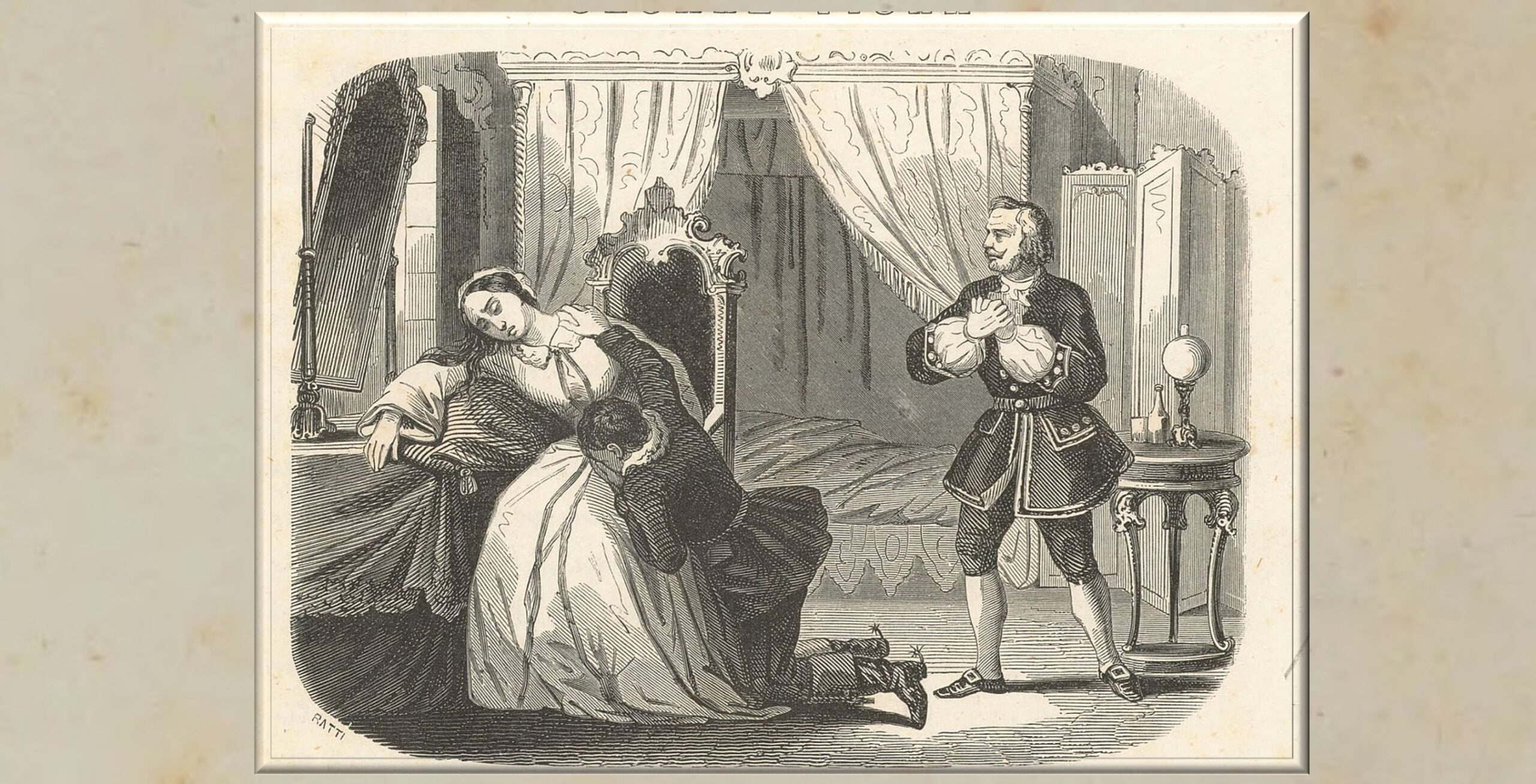Non un bene estraneo: il bene comune e la verità dell’amore
Stephan Kampowski
1. Il mio bene e il tuo
«Tutta la filosofia dell’inferno» – così il diavolo Berlicche istruisce il suo apprendista Malacoda nelle celebri Lettere di Berlicche di C.S. Lewis – «consiste nel riconoscimento dell’assioma che […] il mio bene è mio bene, e il tuo è tuo. Ciò che uno guadagna un altro perde»[1]. Nella Divina Commedia di Dante, ci viene presentata la figura di Guido del Duca, che è stato un fedele seguace di questo modo di vita durante i suoi anni sulla terra. Con gli occhi cuciti, trascorre il suo tempo in Purgatorio sulla terrazza degli invidiosi. Quando arrivano Dante e Virgilio, spiega ai suoi visitatori che sta solo raccogliendo ciò che ha seminato: «Fu il sangue mio d’invidia sì riarso,/ che se veduto avesse uom farsi lieto,/ visto m’avresti di livore sparso»[2]. Prosegue poi formulando la filosofia dell’inferno con parole del tutto simili a quelle di Berlicche, ma aggiungendo una nota di profondo rammarico: «O gente umana, perché poni ‘l core/ là ‘v’è mestier di consorte divieto?»[3].
Ecco, in una sola frase, il segreto dell’invidia, che la Scrittura ci dice essere il vizio caratteristico del demonio – perché è stato «per invidia del diavolo» che «la morte è entrata nel mondo» (Sap 2,24). L’invidia nasce nel nostro cuore quando cerchiamo beni che non possono essere condivisi. Il tuo bene mi è estraneo. Il mio bene è privato e il tuo bene è, dal mio punto di vista, privativo, mi priva di qualcosa: la tua ricchezza è la ricchezza che io non ho; il tuo onore è l’onore che io non ho ricevuto. Quindi, come dice Berlicche, «“Essere” significa “essere in competizione”»[4]. Il tuo successo è il mio fallimento, il mio onore è la tua vergogna. È questo avviene, come spiega Virgilio a Dante, “perché s’appuntano i vostri disiri/ dove per compagnia parte si scema,/ invidia move il mantaco a’ sospiri”[5].
La filosofia del cielo è certamente diversa e Virgilio cerca di spiegarla in questo modo: «Ma se l’amor de la spera supprema/ torcesse in suso il disiderio vostro,/ non vi sarebbe al petto quella tema;/ ché, per quanti si dice più lì “nostro”,/ tanto possiede più di ben ciascuno,/ e più di caritate arde in quel chiostro»[6]. Dante, da parte sua, è ancora perplesso. Pone alla sua guida una domanda che è centrale per l’antropologia e l’etica. Si tratta di un interrogativo a cui bisogna rispondere per comprendere l’idea della verità dell’amore e che ci guiderà per il resto di questo saggio: «Com’esser puote ch’un ben, distributo/ in più posseditor, faccia più ricchi/ di sé, che se da pochi è posseduto?»[7].
2. Vivere e vivere bene
Nella tradizione, i tipi di beni che soddisfano il requisito espresso dal poeta e dalla sua guida – più sono “nostri”, più ricchi diventano i singoli possessori – sono stati chiamati “beni comuni”. Nell’Etica Nicomachea, Aristotele dice che il bene è «ciò a cui tutto tende»[8]. Gli esseri desiderano il bene perché il bene è ciò che perfeziona la loro natura. Pertanto, quello che un essere desidera dipende dal tipo di essere che è, poiché il bene soddisfa la sua natura. I concetti di bene e natura sono quindi strettamente correlati e reciprocamente impliciti. La questione del bene umano è quindi una problematica che riguarda chi e cosa siamo in quanto persone umane. Ci sono certamente dei beni di cui abbiamo bisogno per sopravvivere: cibo, vestiti, riparo. Ma questi da soli, per quanto necessari, non sono sufficienti per vivere bene. Gli esseri umani, come tutti gli esseri viventi, sono in una tensione che Aristotele esprime con i termini zēn ed euzēn, vivere e vivere bene[9]. Possiamo avere tutto ciò che ci serve per sopravvivere, ma potremmo non vivere bene. E questo è ciò che vogliamo veramente nella vita: vogliamo che le nostre vite riescano come vite umane; vogliamo non solo vivere, ma prosperare.
Di che cosa abbiamo bisogno per non limitarci a sopravvivere, ma per vivere bene? Lasciamo che la nostra immaginazione si scateni per un momento. Pensiamo a queste alternative: come cibo, non solo il pane, ma le bistecche di manzo argentino; come bevanda, non solo l’acqua, ma il whisky single malt delle Highlands invecchiato di trent’anni; come riparo, non solo un modesto rifugio, ma una villa di venti stanze; come mezzo di trasporto, non solo le proprie gambe, ma una Lamborghini Revuelto gialla nuova di zecca; per l’intrattenimento, non solo un semplice apparecchio televisivo, ma uno smart tv a schermo piatto da ottanta pollici con audio Dolby Surround. Possedere e utilizzare questi beni significa fiorire? Possiamo capire la loro desiderabilità. Ma questi sono ovviamente alcuni fra i beni a cui Guido del Duca, se fosse vivo oggi, avrebbe aspirato. Sono questi i beni che in purgatorio avrebbe giudicato come tali da escludere la compagnia e quindi in grado di suscitare invidia. Vedo il cibo delizioso che mangi e le bevande preziose che bevi e che io non posso permettermi, e sono invidioso. Vedo la macchina che guidi e che io non ho i soldi per comprare, e sono invidioso. Ti disprezzo per la tua fortuna e sono tentato di rovinartela. L’invidia dei ricchi da parte dei poveri, l’invidia di chi “ha” da parte di chi “non ha”, è un fenomeno storicamente comune e psicologicamente comprensibile. Il fenomeno dell’invidia è anche il motivo per cui i ricchi tendono a separarsi dai poveri e da tutti gli altri, compresi gli altri ricchi.
Si può dire che i ricchi prosperino con tutti questi beni? Il loro problema principale sembra essere l’invidia che suscitano negli altri. Immaginate quindi che vi venga offerta una villa, del whisky, un’auto sportiva (con tanto di autodromo privato), un sofisticato sistema di home theater e del cibo delizioso, il tutto da godersi – liberi dall’invidia altrui – su un’isola deserta dove dovrete impegnarvi a rimanere da soli per i prossimi dieci anni. L’isola è ricca di provviste, barili di vino e whisky, e il cibo fresco viene portato da droni. E soprattutto, non c’è nessun’altra anima con cui litigare per la distribuzione di questi beni, nessuno che possa rimproverare al fortunato residente la sua bistecca di manzo o che gli graffi la Lamborghini per invidia. Qualcuno vorrebbe andarci?
È presumibile che i lettori esiteranno. Anche se l’idea di godere di tutti i beni e piaceri privati della vita moderna può essere allettante, il prezzo potrebbe vanificare l’affare. Dopo tutto, vivere dieci anni come Robinson Crusoe con un’auto sportiva esclusiva non è molto diverso dal vivere dieci anni come Robinson Crusoe senza un’auto sportiva esclusiva. Manca qualcosa, qualcosa di più importante di tutto il divertimento offerto da questa ipotetica isola del piacere: qualcuno con cui parlare, qualcuno con cui comunicare. Questo era il problema principale di Chuck Noland, il personaggio interpretato da Tom Hanks nel film Cast Away (2000) di Robert Zemeckis. Noland è sopravvissuto a un incidente aereo nell’oceano, riuscendo a mettersi in salvo su un’isola deserta e a cavarsela, benché unico superstite, sviluppando un’abilità nella pesca e una spiccata capacità di adattamento alla vita sull’isola. Tuttavia, qualcosa mancava, e sarebbe mancato anche se la sua vita sull’isola fosse stata più comoda e lussuosa. In effetti, era sul punto di impazzire per la solitudine tanto da scegliersi come unico “interlocutore” un pallone da pallavolo, che chiamò Wilson e che divenne il suo unico compagno per quattro anni.
Secondo Aristotele, per vivere bene, gli esseri umani necessitano di vivere insieme agli altri. La polis, la città, una forma di associazione umana basata sulla giustizia e sul diritto, esiste non solo per la vita, intesa come sopravvivenza, ma anche per la vita buona, per il prosperare: per permetterci di vivere bene come esseri umani[10]. Per loro natura, gli esseri umani sono “animali politici”[11], dotati del logos, del linguaggio, che permette loro di dialogare, di discutere su ciò che è utile e ciò che è dannoso, sul bene e sul male, sul giusto e sull’ingiusto[12]. Ora, il tipo di bene che corrisponde alla natura sociale o politica dell’essere umano è proprio il bene comune, che san Tommaso definisce «migliore e più divino che non il bene del singolo»[13]. Ma qual è il significato preciso del bene comune e qual è il suo rapporto con la singola persona? Per rispondere a queste domande, esamineremo prima la nozione di bene comune nella modernità e poi cercheremo di recuperare l’idea classica.
3. Una moderna repubblica di diavoli
All’inizio della modernità, il discorso sul bene comune ha subito una profonda trasformazione. Per Immanuel Kant, la polis o città stato non era più il luogo in cui si realizzavano le più alte possibilità degli esseri umani, il luogo in cui essi fiorivano nel godimento del bene comune. Per lui, piuttosto, «il problema dell’istituzione dello Stato […] è risolvibile anche per un popolo fatto di diavoli (a patto che abbiano intelletto)»[14]. Non c’è bisogno di buona volontà tra gli esseri umani; non è un prerequisito che le persone si amino o che siano giuste e si preoccupino del bene comune. Paradossalmente, per Kant, può esistere una repubblica senza che i suoi cittadini mostrino alcun interesse per la res publica, la “cosa pubblica” che li unisce. È sufficiente che siano interessati a sé stessi, perseguendo i loro fini egoistici individuali come farebbero i diavoli. Un abile legislatore dovrebbe essere in grado di manipolare le persone in modo che, mentre ciascuno persegue solo i propri interessi individuali, i cittadini agiscano comunque in modo conveniente per l’insieme[15]. Per Kant, non c’è bisogno che i cittadini abbiano buone intenzioni gli uni verso gli altri o che si curino della loro comunità. Per un tale approccio, l’unica accezione di “bene comune” rimasta è quella della somma dei beni individuali.
Il bisogno di concepire leggi adatte a mantenere una repubblica di diavoli è sorto quando la modernità ha iniziato a considerare gli esseri umani come fondamentalmente egoisti. Molti considerano Thomas Hobbes come uno dei fautori di questa prospettiva. A lui si attribuisce la famosa affermazione homo homini lupus – «l’uomo è un lupo per l’uomo»[16]. Per correttezza nei confronti di Hobbes, questa affermazione deve essere contestualizzata. Infatti, Hobbes scrive che: «Certamente è altrettanto vero che l’uomo è per il suo simile un dio, quanto che esso è per il suo simile, un lupo: quello, se poniamo a confronto i singoli cittadini; questo, se guardiamo agli Stati»[17]. Una volta che c’è una città, costituita da un contratto sociale, gli esseri umani si rispettano reciprocamente, secondo Hobbes. Sono lupi l’uno verso l’altro, non nelle relazioni civili all’interno della città, ma nelle relazioni tra le città, dove non ci sono leggi o istituzioni giuridiche superiori per ritenere le città (poleis = città stato) responsabili. Inoltre, l’espressione homo homini lupus non è una formulazione propria di Hobbes. Risale piuttosto all’antico commediografo romano Tito Maccio Plauto (254-184 a.C.)[18].
Nonostante queste precisazioni, i commentatori hanno certamente ragione a considerare Hobbes come uno dei padri dell’individualismo moderno. Per lui la città, o più precisamente lo Stato, esiste per evitare che le persone si uccidano a vicenda. In un ipotetico e mitico stato di natura, ogni individuo avrebbe rivendicato il diritto di usare la forza fisica per far prevalere i propri interessi su quelli degli altri. La paura di una morte violenta e il desiderio di tranquillità hanno portato le persone a cedere il ricorso a mezzi violenti al Leviatano, lo Stato[19]. Con il Leviatano che li protegge gli uni dagli altri, i cittadini hanno la loro tranquillità e possono dedicarsi ai loro affari privati. La libertà politica sembra essere una sorta di libertà dalla politica, la libertà di non doversi occupare della cosa pubblica e di poter perseguire i propri interessi privati e individuali.
Adam Smith va nella stessa direzione. Secondo lui il governo civile è stato «istituito per la difesa dei ricchi contro i poveri o di coloro che hanno un poco di proprietà contro coloro che non ne hanno affatto»[20]. Anche in questo caso, ciò implica una visione degli esseri umani come fondamentalmente egoisti, che vivono nelle città solo per comodità, per vivere, per sopravvivere, ma non per vivere bene[21]. Eppure, magicamente, attraverso una “mano invisibile”, i mercati fanno per Smith lo stesso miracolo che le leggi della repubblica fanno per Hobbes o Kant. Tutti coloro che sono impegnati a promuovere i loro interessi personali e privati allo stesso tempo, senza preoccuparsi del bene comune, promuovono anche il bene degli altri. Il mercato è un’istituzione attraverso la quale si perseguono i propri interessi egoistici, si cerca di accrescere i propri profitti attraverso lo scambio, arricchendo così in modo accidentale anche gli altri. Ma non è l’arricchimento degli altri a motivare l’attività di mercato. Tutti i partner commerciali sono interessati solo al loro profitto privato. Ovviamente, in un certo senso è vero che cercano la stessa cosa e condividono un obiettivo comune: il profitto economico. Ma questo “bene comune” deve essere inteso come somma dei beni privati individuali.
4. Il bene comune come causa finale
La tradizione, tuttavia, conosce un tipo di bene comune che è più della somma dei beni privati, un bene che è comune non solo per nome o per “predicazione”, come quando tu cerchi il tuo guadagno monetario e io cerco il mio. Qui, la cosa “comune” che cerchiamo è comune solo di nome[22]. Entrambi perseguiamo lo stesso tipo di cosa (il guadagno monetario), eppure non si tratta di un obiettivo veramente comune, poiché non è numericamente uno: il tuo guadagno non è il mio e il mio non è il tuo. Esiste invece un bene comune, come concepito dalla tradizione, che è comune non solo per predicazione ma anche “per causalità”, per modum causae[23]. Il bene comune in questo senso è pensato come una causa che è numericamente una e che estende i suoi effetti a molti, in modo analogo a come il sole produce luce e calore per tutti gli esseri sulla terra[24]. La causalità del bene comune è quella di una causa finale[25].
Una causa finale causa attraendo, motivando, essendo un obiettivo. Possiamo chiederci perché un ragazzo stia correndo verso la stazione ferroviaria. Apprendiamo che è in ritardo e che sta facendo ogni sforzo per raggiungere il treno. Ma comprendiamo davvero la sua azione solo quando scopriamo perché per lui è così importante prendere quel treno. Ciò che rende il viaggio di quest’uomo così essenziale è la causa finale, ad esempio la persona che vuole incontrare nella città in cui sta andando: la sua fidanzata. Solo ora possiamo dire di aver capito veramente il perché del suo correre[26]. È l’amore per lei e per la loro comune amicizia, l’amore per un bene specifico che lo motiva. La questione dell’amore che motiva può essere portata al livello di un principio generale. Tommaso d’Aquino sostiene che ogni agente, di qualsiasi tipo, fa tutto ciò che fa per un qualche amore[27]. E Dante, da parte sua, parla dell’amore «che move il sole e l’altre stelle»[28]. Capire un’attività significa capire l’amore che la spinge. Senza questo amore, non ci sarebbe movimento, ed è per questo che Tommaso chiama la causa finale «la causa delle cause»[29].
Ora, il bene comune che è comune come causa finale è, in quanto buono, desiderabile e tale da muovere l’agente all’azione. In quanto comune, è un principio di unione tra i vari agenti che lo hanno come fine. Aristotele fa l’esempio del figlio come bene comune dei genitori[30]. Anche se nelle dispute per l’affidamento può accadere che un padre o una madre considerino il bambino come un bene privato, è un dato di fatto che il bambino non appartiene né solo al padre né solo alla madre, ma a entrambi, poiché nessuno di loro da solo è stato in grado di dare la vita al bambino. Hanno agito come causa comune nella generazione del figlio. Ora il bambino, una volta generato, è un bene per i suoi genitori: un bene comune che li unisce nei loro sforzi per educarlo, farlo sopravvivere e prosperare. Infatti, quando una coppia manca di questo scopo comune a causa della sterilità, il rischio di separazione è maggiore, come già nei tempi antichi aveva notato Aristotele. Il bene comune, l’obiettivo comune, lo scopo comune unisce, e unisce nell’azione, in un’attività comune. Per questo Karol Wojtyła parla di “legame del bene comune”: si tratta di un legame speciale che «non si limita al fatto che due esseri tendano insieme ad un bene comune, ma unisce anche “dall’interno” le persone che agiscono, e in questo modo costituisce il nucleo di ogni amore. In ogni caso non si può immaginare un amore tra due persone senza questo bene comune che li leghi e che sarà nello stesso tempo il fine che avranno scelto insieme»[31].
5. L’analogia del bene comune
Il bene comune è un concetto analogico. Qualsiasi bene vero, qualsiasi oggetto di appetito idoneo, che possa unire due o più persone in un’attività comune nel suo perseguimento o nella sua realizzazione, è un bene comune. Può trattarsi di una “sostanza” – un individuo esistente in sé – come nel caso di un bambino. I genitori perseguono il benessere del figlio come compito comune; il benessere del figlio è un autentico bene per i genitori del bambino, un bene che condividono, un bene comune. Ma il bene comune può anche essere una relazione o un’attività, e qui l’essenza della sua “comunanza” diventa ancora più evidente, perché in questo caso i beni comuni non hanno un’esistenza indipendente dall’essere tenuti in comune. Possiamo quindi pensare all’amicizia come a un bene comune[32]. A quale degli amici appartiene la loro amicizia? L’amicizia o è tenuta in comune o non esiste. Nessuno degli amici può avere l’amicizia solo per sé. L’amicizia, per definizione, è un tipo specifico di relazione tra due o più persone. Ora, l’amicizia è un grande bene e si può farne l’oggetto delle proprie attività e coltivarla deliberatamente. Tommaso chiama il matrimonio la più grande delle amicizie[33], e quando i coniugi lottano per il loro matrimonio in tempi di crisi, lo considerano consapevolmente un bene comune che vale la pena salvaguardare e preservare.
Anche la famiglia è un bene comune relazionale. I singoli membri della famiglia non possono mai rivendicare la loro comunione familiare come un bene privato. È un bene intrinsecamente nostro. E man mano che la famiglia cresce, man mano che un numero maggiore di persone la reclama come propria, nessun singolo membro ne ha di conseguenza di meno. La famiglia, intesa come bene comune, sembra essere un ottimo esempio per aiutarci a vedere la verità delle parole quasi paradossali con cui abbiamo iniziato questo saggio e che Dante ha messo in bocca a Virgilio: «Per quanti si dice più lì “nostro”,/ tanto possiede più di ben ciascuno»[34]. È proprio questo il punto che san Giovanni Paolo II sottolinea nella sua Lettera alle famiglie del 1994. Quando si aggiungono membri alla famiglia, gli altri non ne risultano più poveri, ma più ricchi:
Il figlio viene ad occupare dello spazio, mentre di spazio nel mondo sembra essercene sempre meno. Ma è proprio vero che egli non porta niente alla famiglia ed alla società? Non è forse una “particella” di quel bene comune, senza del quale le comunità umane si frantumano e rischiano di morire? Come negarlo? Il bambino fa di sé un dono ai fratelli, alle sorelle, ai genitori, all’intera famiglia. La sua vita diventa dono per gli stessi donatori della vita, i quali non potranno non sentire la presenza del figlio, la sua partecipazione alla loro esistenza, il suo apporto al bene comune loro e della comunità familiare[35].
Quanto maggiore è il numero di coloro che dicono: “Questa è la nostra famiglia”, tanto maggiore è il bene che ogni membro della famiglia possiede.
Mentre, come obiettivo comune, il bene comune implica sempre che le persone agiscano in vista di esso con un’attività concertata e comune, esso può anche consistere nella stessa attività comune. Una partita di calcio è un bene per ogni partecipante. Ma a chi appartiene e dove “risiede” esattamente? Nessuna delle attività individuali dei singoli giocatori costituisce la partita di calcio. La partita di calcio consiste nell’insieme delle azioni coordinate di tutti i calciatori e, in quanto tale, è superiore alla somma delle sue parti. La partita di calcio è un’attività che può esistere solo come la nostra. Lo stesso vale per un concerto con più di un interprete. Immaginiamo un coro che canti con voci diverse. La canzone cantata in armonia è più grande del contributo individuale di ciascuna voce. Oppure pensiamo a una conversazione intelligente tra amici. Nessuno dei partecipanti potrebbe sostenere la conversazione da solo. È un bene che esiste solo come bene comune.
Un bene comune può essere qualcosa di presente, come l’ordine interno dell’universo[36], o può essere uno stato futuro da realizzare, come la vittoria dell’esercito[37]. I beni comuni possono essere voluti per sé stessi, come nel caso di un concerto di molti musicisti o di una discussione filosofica tra amici. Questi beni hanno il loro fine o significato in sé; sono beni “onesti” in quanto degni di essere scelti per sé[38]. I beni comuni possono anche essere beni strumentali[39], come ad esempio l’ordine dell’esercito, che è per la vittoria, che è per la pace e la tranquillità della comunità, la quale, invece, dal canto suo, è un bene comune desiderato per sé stesso[40].
Per tutti questi diversi tipi di beni comuni, è vero che sono condivisi da molti e che il numero dei partecipanti non riduce di per sé la quota di ciascun individuo. Esiste un numero minimo e probabilmente massimo di soldati necessari per avere una divisione funzionante. Ma l’inclusione di un soldato in quella divisione non toglie l’inclusione degli altri soldati nello stesso insieme ordinato. Questi diversi tipi di beni comuni hanno in comune anche il fatto di essere realmente il bene di ogni individuo che vi partecipa. Per ogni musicista che partecipa a un concerto, è vero dire che il concerto è la sua attività e quindi il suo bene, ma non come attività individuale, bensì come attività comune, come bene comune. Lo stesso vale per una conversazione o per l’appartenenza a una società tranquilla e pacifica, governata da leggi giuste e composta da cittadini virtuosi.
Nel tipo di associazioni umane in cui le persone sono unite da un bene comune, non c’è invidia. Il fatto che tutti i membri vogliano la stessa cosa – la vittoria, un bel concerto, una conversazione intelligente – non li pone in uno stato di competizione l’uno con l’altro, ma piuttosto in uno stato di interdipendenza reciproca. L’obiettivo comune unisce perché è comune per causalità. Genera un’attività comune perché può essere raggiunta o attuata solo in quanto comune. D’altra parte, anche i beni privati possono essere “comuni”, ma solo per predicazione. Se due persone desiderano entrambe delle auto sportive veloci, è vero che desiderano lo stesso tipo di cosa. Tuttavia, questo desiderio non li unirà e non instillerà in loro un’attività comune che contribuisca allo stesso fine. In senso stretto, i beni privati, come le auto sportive, non uniscono, ma forniscono piuttosto numerose occasioni di invidia. La mia Porsche non è la tua Ferrari. Perché hai potuto acquistare un’auto di questo tipo eccellente? Perché io non sono stato così fortunato?
6. Il tutto e le parti
L’idea del bene comune come bene proprio della persona presuppone ovviamente una nozione a cui la modernità è estremamente ostile: l’idea che la persona sia parte di un insieme più grande, e che sia chiamata ad amare più di sé stessa. Come dice san Tommaso d’Aquino, «La nozione di bene comune è diversa da quella di bene privato [boni singularis], come diverse sono le nozioni di tutto e di parte»[41]. Soprattutto dopo l’esperienza delle forme di governo totalitarie della metà del secolo scorso, troviamo sconcertante considerare la persona come una parte. Pensare a una persona come a una parte non equivale forse a renderla uno strumento? Non è forse la grande conquista dell’Illuminismo l’aver proclamato la dignità incondizionata di ogni singolo essere umano, che deve essere sempre trattato come un fine e mai come un semplice mezzo? La domanda è che cosa intendiamo quando diciamo che la persona è parte di un tutto. E occorre chiedersi se esiste un modo di essere una tale parte che non equivalga a ridurre la persona al rango di mero strumento.
Per rispondere, cominciamo con un articolo molto istruttivo della Summa Theologiae, dedicato alla questione se la persona umana sia obbligata ad amare Dio più di sé stessa[42]. La risposta di Tommaso è un “sì” senza equivoci, poiché Dio è il bene comune di tutti e «qualsiasi parte ama naturalmente più il bene comune del tutto, che il bene proprio particolare»[43]. Egli sostiene che «in qualsiasi parte si riscontra come inclinazione principale la tendenza a compiere degli atti collettivi per il vantaggio del tutto», il che si vede «persino nelle virtù politiche (o sociali), che spingono i cittadini a sopportare il danno delle proprie sostanze e talora della propria persona, per il bene comune»[44]. La persona umana è una parte dell’universo il cui fine, scopo o obiettivo è quello di riflettere la gloria di Dio e quindi di lodarlo tramite il suo ordine nelle attività concertate delle sue parti. “I cieli narrano la gloria di Dio”, così come tutte le altre realtà create con il loro stesso essere e la loro attività o, per dirla con le parole di Giovanni Paolo II, «la gloria di Dio è il bene comune di tutto ciò che esiste»[45]. Nella maggior parte dei casi, la persona umana è inoltre parte di comunità, che anche oggi può talvolta chiamare alcuni dei suoi cittadini a rischiare la vita per il suo bene: dai vigili del fuoco agli agenti di polizia, ai soldati. Tutti amano la loro città più di sé stessi e, seguendo la logica di san Tommaso, non fanno nulla di irragionevole. Quando un uomo muore per i suoi amici, per la sua famiglia, per il suo Paese o per il suo Dio, muore per un bene comune di cui fa parte, che è più grande di qualsiasi suo bene privato e che è allo stesso tempo il suo bene più proprio. Lo stesso vale per l’estremo sacrificio che una donna compie per coloro che ama.
Essere parte non significa essere ridotti a un mero mezzo o strumento. Il bene comune di cui la persona fa parte non è un bene estraneo, ma il vero bene dell’individuo che si realizza in un’attività comune. Karol Wojtyła esprime la possibilità di tale realizzazione con il termine “partecipazione”. Per lui la partecipazione si riferisce a una «peculiarità della persona, in virtù della quale l’uomo, esistendo e operando insieme con gli altri, è capace di compiersi, di realizzarsi in questo agire e in questo esistere»[46]. Per esempio, essere amico significa essere parte di un insieme più grande, cioè l’amicizia. Eppure questo essere parte non strumentalizza in alcun modo la persona. Partecipazione significa che il compimento della nostra amicizia è il mio compimento; il compimento della nostra famiglia è il mio compimento; il compimento della nostra città o nazione è il mio compimento. Il bene comune, come dice Benedetto XVI, è «il bene di quel “noi-tutti”, formato da individui, famiglie e gruppi intermedi che si uniscono in comunità sociale»[47]. Il bene comune non può essere inteso semplicemente come il bene di molti o il bene della maggioranza, ma deve essere comune nel senso più pieno del termine: deve essere il bene di “tutti noi”, senza escludere nessuno.
I regimi totalitari del secolo scorso non hanno permesso ai cittadini di essere uniti in un bene comune. Non hanno lasciato spazio alla partecipazione, ma hanno deliberatamente promosso l’alienazione. Si parlava di nazione “comune” o di classe “comune”, in nome della quale gli individui venivano sacrificati, esclusi dal progetto comune e eliminati dalla faccia della terra. Ad esempio, i contadini che Stalin espropriò e giustiziò per il “progresso” della Russia e dell’Unione Sovietica non potevano certo partecipare al “bene comune” del loro Paese.
Seguendo una logica analoga, si può immaginare un ufficiale di polizia che incastri un innocente per evitare violente rivolte a seguito di un crimine particolarmente odioso, il cui vero perpetratore purtroppo non sia stato individuato. Presentando alla folla inferocita una vittima adatta da condannare a morte, il poliziotto è riuscito a calmare la situazione. Così facendo ha forse ristabilito la pace e la tranquillità dell’ordine civile e ha lavorato per il bene comune della città? Il fatto è che la pace e la tranquillità dell’ordine civile, il bene comune della città, non consiste semplicemente nell’assenza di disordini. Il bene comune della città include la presenza della giustizia[48], che garantisce che i cittadini non vengano accusati e condannati per crimini che le autorità sanno benissimo non essere stati da loro commessi. L’uomo incastrato dal poliziotto e escluso dal bene comune della città potrebbe essere in qualche modo ogni uomo e ogni donna. Pertanto, il poliziotto ha gravemente danneggiato il bene comune della città. Perché il bene comune sia veramente tale, non può escludere nessuno, ma deve appartenere a tutti. A questo proposito, il Compendio della Dottrina sociale della Chiesa sottolinea che: «Il bene comune non consiste nella semplice somma dei beni particolari, di ciascun soggetto del corpo sociale, essendo di tutti e di ciascuno, rimane comune perché indivisibile e soltanto insieme è possibile raggiungerlo, farlo crescere e custodirlo anche in vista del futuro»[49].
7.
L’apprezzamento del bene comune apre nuove prospettive sulla questione di cosa significhi amare nella verità. Qual è il tipo di amore che corrisponde alla realtà dei nostri desideri più profondi e della nostra vocazione ultima? Gran parte dell’attuale dibattito etico e antropologico è imbrigliato nella dialettica tra egoismo e altruismo. L’egoismo, l’amore per sé stessi escludendo tutti gli altri, è spesso considerato la condizione umana più o meno naturale. L’altruismo è ritenuto un amore “puro” in cui una persona rinuncia ai propri interessi per il bene degli altri, un amore che, pur essendo lodevole, è tanto eccezionale quanto misterioso e inspiegabile in termini di motivazione umana. Nel frattempo, ci viene detto che essere altruisti, pensare al bene degli altri a scapito del proprio, significa essere moralmente buoni, mentre essere egoisti, pensare al proprio bene a scapito degli altri, equivale a essere moralmente cattivi. Questa visione, tuttavia, significa concepire la morale come qualcosa di ostile alla vita[50], ed esclude in modo controfattuale la possibilità che qualcuno possa mai commettere atti cattivi per motivi altruistici. Anche se non abbiamo bisogno di andare al di là del bene e del male, come sosteneva Friedrich Nietzsche[51], dobbiamo comunque andare al di là dell’altruismo e dell’egoismo. Ed è proprio questo che l’amore per il bene comune ci permette di fare. L’idea del bene comune ci dice che i nostri veri interessi in quanto esseri umani, i nostri beni propri, risiedono nei beni comuni. Come dice Alasdair MacIntyre: «Il mio bene in quanto uomo coincide assolutamente con il bene di quegli altri con cui sono legato in una comunità umana. Non esiste alcun mezzo con cui io posso perseguire il mio bene che sia necessariamente in conflitto con il tuo perseguimento del tuo, perché il bene non è né mio né tuo in particolare: i beni non sono proprietà privata»[52]. Non si tratta né di egoismo, per cui preferisco il mio bene al tuo, né di altruismo, per cui preferisco il tuo bene a scapito del mio, ma di capire che il mio vero bene sta nel nostro bene, così come il tuo.
L’amore per il bene comune ci permette di vedere l’amore per noi stessi e l’amore per gli altri da una prospettiva completamente nuova. San Giovanni Paolo II suggerisce qualcosa in questo senso quando scrive, forse in modo un po’ enigmatico: «L’uomo è un bene comune: bene comune della famiglia e dell’umanità, dei singoli gruppi e delle molteplici strutture sociali»[53]. Qui ci invita ad adottare una prospettiva che ci permetta di comprendere noi stessi e la nostra vita come un bene comune, in modo che l’amore di sé assuma un significato completamente nuovo e perda ogni ombra di egoismo. La nostra vita non ci appartiene. Possiamo guardarla anche dal punto di vista di coloro con cui siamo uniti dalla condivisione di un bene comune: un’amicizia, una famiglia, una città, una nazione. Per esempio, Robert Spaemann racconta di aver visto un adesivo applicato sul paraurti con su scritto: «Non correre, pensa a tua moglie!»[54]. Il marito può amare sé stesso dal punto di vista della moglie, cioè come suo marito, come colui che lei ama e che è unito a lei da un legame speciale di amicizia che coinvolge tutta la loro vita. In altre parole, può anche amare la propria esistenza dal punto di vista del bene comune, poiché la sua vita non è semplicemente un bene privato, ma una parte essenziale del bene comune che è il suo matrimonio e la sua famiglia.
Perché dovrei preoccuparmi non solo del mio modo di guidare, ma anche della mia salute, della mia educazione, della mia carriera? Perché dovrei preoccuparmi di continuare a vivere? Quando san Tommaso elenca tre degli argomenti più forti contro il suicidio che riesce a trovare nella tradizione cristiana, uno di questi si basa proprio sul bene comune. Secondo questo argomento, il suicidio è assolutamente illecito «perché la parte è essenzialmente qualche cosa del tutto. Ora, ciascun uomo è parte della comunità, e quindi appartiene essenzialmente alla comunità. Perciò uccidendosi fa un torto alla comunità, come insegna il Filosofo»[55]. Il torto fatto alla società uccidendo sé stessi non riguarda solo e non principalmente la propria “utilità” per la comunità. Si tratta del fatto che facciamo parte della società: la società degli amici, della famiglia, dei cittadini e di qualsiasi altra associazione a cui partecipiamo, dalla squadra di calcio amatoriale al club di giardinaggio. Il nostro vivere e il nostro morire influenzano gli altri, che lo vogliamo o no, che ne siamo consapevoli o no. L’unica ragione per cui siamo sopravvissuti alla nostra infanzia è che qualcuno ci ha amato. Siamo naturalmente inseriti nelle relazioni sociali. Come dice l’apostolo Paolo: «Nessuno di noi, infatti, vive per sé stesso e nessuno muore per sé stesso» (Rm 14,7).
Anche quando voglio fare del bene a me stesso, sono chiamato ad amarmi nella prospettiva dell’insieme più grande di cui faccio parte: un’amicizia di qualsiasi tipo, il mio matrimonio se sono sposato, la mia famiglia, la mia città e la mia nazione, la mia parrocchia e la mia diocesi, la Chiesa universale. E quando voglio un bene per i miei amici, per mia moglie e i miei figli (se ne ho), per la mia famiglia, per la mia nazione e per la Chiesa, non voglio un bene estraneo. In ultima analisi, agisco per il bene della comunione[56], un bene che «distributo/ in più posseditor, faccia più ricchi/ di sé, che se da pochi è posseduto»[57].
* Docente stabile di Antropologia filosofica presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienza del Matrimonio e della Famiglia.
[1] C.S. Lewis, Le lettere di Berlicche, trad. it. A. Castelli, Mondadori, Milano 1998, 73-74.
[2] Dante Alighieri, La Divina Commedia. Purgatorio, BUR, Milano 1975, canto XIV, vv. 82-84. È stato l’eccellente articolo di G. Froelich, “Friendship and the Common Good”, in The Aquinas Review 12 (2005) 37-58, a portare la mia attenzione su questo passo di Dante.
[3] Dante, Purgatorio, cit., canto XIV, vv. 86-87.
[4] C.S. Lewis, Le lettere di Berlicche, cit. 74 (enfasi originale).
[5] Dante, Purgatorio, cit., canto XV, vv. 49-51.
[6] Dante, Purgatorio, cit., canto XV, vv. 52-57.
[7] Dante, Purgatorio, cit., canto XV, vv. 61-63 (enfasi dell’autore).
[8] Aristotele, Etica Nicomachea, in Id., Le tre etiche, Bompiani, Milano 2008, 433; I, 1, 1094a.
[9] Cfr. Aristotele, Dell’anima, a cura di P. Eusebietti, Paravia, Torino 1931, 163; III, 13, 3; 435b19. Su questo si veda R. Spaemann, Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, trad. it. L. Allodi, Laterza, Roma-Bari 2005: «Gli uomini, nella misura in cui sono esseri viventi, partecipano anche di quella differenza che Aristotele definisce come la caratteristica di tutti gli esseri viventi superiori: la differenza tra zen e eu zen, tra vivere e vivere bene».
[10] Aristotele, Política, vol. I (Libri I-IV), Fondazione Lorenzo Valla – Mondadori, Milano 2014, 9; I, 2, 1252b30: «Essa [la polis] è nata per assicurare la vita, si realizza nel garantire una buona vita».
[11] Aristotele, Política, vol. I (Libri I-IV), cit., 9; I, 2, 1253a3.
[12] Aristotele, Política, vol. I (Libri I-IV), cit., 11; I, 2, 1253a7-18: «L’essere umano è l’unico vivente ad avere la parola e, se la voce, in quanto espressione di dolore e di piacere, appartiene anche agli altri animali (perché nel loro caso sino a tal punto e non oltre si è spinta la natura, cioè fino a provvederli della sensazione di dolore e di piacere e della possibilità di comunicarla ad altri), la parola è in grado di manifestare l’utile e il dannoso e, di conseguenza, anche il giusto e l’ingiusto. E ciò, a paragone con gli altri animali, è un carattere peculiare dell’uomo, il quale è il solo ad avere percezione di ciò che è buono e cattivo, giusto e ingiusto, e di altro ancora; è proprio la condivisione [koinōnia] di tali valori che dà origine al nucleo familiare e alla città».
[13] San Tommaso d’Aquino, Commento alla Politica di Aristotele, a cura di L. Perotto, ESD, Bologna 1996, 47; libro 1, capitolo 1, n. 2.
[14] I. Kant, Per la pace perpetua, trad. it. R. Bordiga, Feltrinelli, Milano 1991, 76.
[15] Cfr. I. Kant, Per la pace perpetua, cit.: «È questa la […] formulazione [del problema]: «Ordinare una massa di esseri ragionevoli, che per la loro conservazione esigono tutti insieme leggi generali, ognuno dei quali però ha la segreta tendenza a sottrarsi a esse, e istituire una costituzione in modo tale che benché nei loro sentimenti privati si oppongano l’uno contro l’altro, questi sentimenti si frenino a vicenda così che nel loro comportamento pubblico il risultato sia come se quei cattivi sentimenti non ci fossero affatto”. Un problema del genere deve poter essere risolto».
[16] Th. Hobbes, Elementi filosofici sul cittadino (De cive), a cura di N. Bobbio, UTET, Torino 1948, 52.
[17] Th. Hobbes, Elementi filosofici sul cittadino (De cive), cit.
[18] T.M. Plauto, Asinaria, BUR, Milano 1994, II, 4, v. 494: «Lupus est homo homini».
[19] Cfr. Th. Hobbes, Leviatano, vol. I, a cura di R. Giammanco, UTET, Torino 1955, 131; parte I, cap. XI: «Il desiderio di benessere e di godimento sensuale fa sì che gli uomini obbediscano ad un potere comune, perché a causa di questi desideri, invece di procurarci la nostra protezione attraverso la laboriosità e la fatica, ne affidiamo il compito ad altri. Il timore di morte e di ferite, per la stessa ragione, determina lo stesso comportamento». Cfr. ibid., 237-238, parte II, cap. XX.
[20] A. Smith, La ricchezza delle nazioni, a cura di A. Bagiotti – T. Bagiotti, UTET, Torino 1975, 879-880, libro V, cap. I, parte II.
[21] Questo è infatti il giudizio di Aristotele su coloro che pensano che si «debba consolidare o incrementare illimitatamente il patrimonio pecuniario». Secondo lui, «essi si preoccupano di vivere, e non di vivere bene» (Aristotele, Politica, I, 9, 1257b40).
[22] Cfr. san Tommaso D’Aquino, Sulla verità, a cura di F. Fiorentino, Bompiani, Milano 2005, 553; q. 7, a. 6, ad 7: «Una cosa si dice più comune in due modi: in un modo, per conseguenza o per predicazione, quando cioè qualcosa di uno si riscontra in molte cose secondo un’unica ragione; e in tal caso ciò che è più comune non è più eccellente, ma più imperfetto come l’animale è [più comune e] più imperfetto dell’uomo».
[23] Cfr. san Tommaso D’Aquino, Sulla verità, cit., 553; q. 7, a. 6, ad 7: «In un altro modo [una cosa si dice più comune] per modo di causa, cioè come la causa, che pur rimanendo una di numero, si estende a più effetti; e secondo questo senso ciò che è più comune è anche più eccellente, come la conservazione della città è più eccellente della conservazione della famiglia».
Cfr. A. Guilbeau, “What Makes the Common Good Common? Key Points from Charles de Koninck”, in Nova et Vetera 20 (2022) 739-751.
[24] Cfr. G. Froelich, “The Equivocal Status of Bonum Commune”, in The New Scholasticism 63 (1989) 48.
[25] Cfr. G. Froelich, “The Equivocal Status of Bonum Commune”, cit.: «Now the good is a cause properly as that for the sake of which, as an end or goal. But since a particular good can be the end of many, as victory is for an army, we may also speak of a good common per modum causae».
[26] Cfr. R. Spaemann – R. Löw, Fini naturali. Storia & riscoperta del pensiero teleologico, trad. it. L. Allodi – G. Miranda, Edizioni Ares, Milano 2013, 107: «Nella dottrina aristotelica delle cause, ha il primato la causa finale. Solo quest’ultima consente una soluzione soddisfacente della “questione-del-perché” in ordine alla sua comprensione».
[27] San Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I-II, 28, 6: «Ogni agente, qualunque esso sia, compie qualsiasi atto per un qualche amore».
[28] Dante Alighieri, La Divina Commedia. Paradiso, BUR, Milano 1975, canto XXXIII, v. 145. Per una discussione più ampia su questo versetto, si veda l’articolo di J. Granados, “Love and the Organism. A Theological Contribution to the Study of Life”, in Communio 32 (2005) 1-37, che offre una profonda riflessione su come il corpo e l’amore siano connessi alla libertà.
[29] San Tommaso d’Aquino, De principiis naturae, 3, 29: «Finis est causa causarum, quia est causa causalitatis in omnibus causis».
[30] Aristotele, Etica Nicomachea, cit., VIII, 12, 1162a: «Si ritiene, infatti, che i figli costituiscano un legame [tra marito e moglie], ed è per questo che coloro che non hanno figli si separano più facilmente; infatti i figli costituiscono un bene comune a entrambi, e ciò che è comune rappresenta un legame».
Tommaso d’Aquino commenta questo passo in modo ancora più esplicito: «Filii sunt commune bonum amborum, scilicet viri et uxoris, quorum coniunctio est propter prolem. Illud autem quod est commune continet et conservat amicitiam quae, ut supra dictum est, in communicatione consistit – I figli sono il bene comune di entrambi, cioè del marito e della moglie, la cui unione è per il bene della prole. Ma ciò che è comune contiene e conserva l’amicizia, la quale, come si è detto, consiste nella comunicazione» (Sententia libri Ethicorum, libro VIII, lezione 12, n. 1724; traduzione propria).
[31] K. Wojtyła, Amore e responsabilità, Marietti, Casale Monferrato 1978, 19.
[32] Cfr. di nuovo G. Froelich, “Friendship and the Common Good”, cit.
[33] San Tommaso d’Aquino, Summa contra Gentiles, III, 123: «Inter virum autem et uxorem maxima amicitia esse videtur: adunantur enim non solum in actu carnalis copulae, quae etiam inter bestias quandam suavem societatem facit, sed etiam ad totius domesticae conversationis consortium – Ma tra marito e moglie sembra esserci la più grande amicizia: sono uniti, infatti, non solo nell’atto dell’accoppiamento carnale, che anche tra bestie costituisce una sorta di dolce compagnia, ma anche per la condivisione di tutta l’attività domestica» (traduzione propria).
Anche papa Francesco ha sottolineato questa nozione nella sua Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia, 19 marzo 2016, n. 123, rifacendosi al Dottore Angelico.
[34] Di nuovo: Dante, Purgatorio, cit., canto XV, vv. 55-56.
[35] San Giovanni Paolo II, Lettera alle famiglie Gratissimam sane, 2 febbraio 1994, n. 11 (enfasi originali).
[36] Cfr. san Tommaso d’Aquino, De substantiis separatis, capitolo 12, n. 65: «Optimum autem in rerum universitate est bonum ordinis: hoc enim est bonum commune – Il bene dell’ordine è ciò che c’è di meglio nell’universo delle cose: infatti questo è il bene comune» (traduzione propria).
Sono in debito con Gregory Froelich per l’utilissimo elenco di occorrenze nel corpus thomisticus del termine “bonum commune” nelle sue differenti accezioni: G. Froelich, “The Equivocal Status”, cit., 42n14.
[37] Cfr. san Tommaso d’Aquino, Sententia libri Metaphysicae, libro VII, lezione 2, n. 1303: «Militaris enim pervenit ad victoriam totius exercitus, quae est quoddam bonum commune ex singularibus victoriis huius et illius – L’arte militare ottiene la vittoria di tutto l’esercito, che è un certo bene comune, grazie alle vittorie di questo e di quell’uomo in particolare» (traduzione propria).
[38] San Tommaso parla qui di “bonum honestum”, che «vien desiderato come scopo ultimo e che termina totalmente il moto dell’appetito, come cosa verso la quale il desiderio tende direttamente» (Summa Theologiae, I, 5, 6).
[39] San Tommaso parla qui del “bonum utile”, che «termina solo relativamente il moto dell’appetito, come mezzo per tendere ad altro» (Summa Theologiae, I, 5, 6). Nello stesso articolo, il Dottore Angelico parla anche del “bonum delectabile”, il bene piacevole.
[40] Si veda il modo in cui Gregory Froelich sintetizza l’insegnamento dell’Aquinate in “The Equivocal Status”, cit., 53: «L’ordine politico, dunque, è un bene per ogni cittadino che vi appartiene. È un bene comune intrinseco. È il fine del diritto, la prima preoccupazione del governante giusto, il bene a cui tutti i cittadini ordinano le loro azioni virtuose – un bene della classe del bonum honestum, degno di essere scelto per sé stesso. Come tutti i soldati di un esercito cercano di promuovere il suo ordine, come fine comune, così i cittadini cercano di promuovere l’ordine proprio della comunità politica. Ma la differenza è che, mentre la vittoria è un mezzo per raggiungere la pace, l’ordine politico è un fine in sé» (traduzione propria).
[41] San Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II, 58, 7, ad 2.
[42] San Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II, 26, 3.
[43] San Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II, 26, 3.
[44] San Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II, 26, 3.
[45] San Giovanni Paolo II, Gratissimam sane, n. 11 (corsivi originali). Per uno sviluppo di questa idea, si veda M. Waldstein, Glory of the Logos in the Flesh. Saint John Paul’s Theology of the Body, Sapientia Press, Ave Maria, Florida 2021.
[46] K. Wojtyła, “La persona: soggetto e comunità”, in Id., Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, a cura di G. Reale – T. Styczeń, Bompiani, Milano 2003, 1356.
[47] Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 29 giugno 2009, n. 7.
[48] Nella Summa Theologiae, I-II, 19, 10, l’Aquinate arriva persino a identificare il bene comune sociale o politico con la giustizia, quando parla del giudice che «ha cura del bene comune, cioè della giustizia».
[49] Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005, n. 164 (enfasi originale).
[50] Cfr. F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, trad. it. F. Masini, Adelphi, Milano 1977.
[51] F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, cit.
[52] A. MacIntyre, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale, trad. it. M. D’Avenia, Armando Editore, Roma 2007, 276 (traduzione italiana leggermente modificata).
[53] San Giovanni Paolo II, Gratissimam sane, n. 11 (corsivi originali).
[54] R. Spaemann, Felicità e benevolenza, trad. it. M. Amori, Vita e Pensiero, Milano 1998, 123.
[55] San Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II, 64, 5.
[56] Cfr. L. Melina, “Agire per il bene della comunione”, in Id., Cristo e il dinamismo dell’agire, PUL-Mursia, Roma 2000, 37-51.
[57] Dante, Purgatorio, cit., canto XV, vv. 61-63.
Condividi questo articolo
Chi siamo
Il Veritas Amoris Project mette al centro la verità dell’amore come chiave di comprensione del mistero di Dio, dell’uomo e del mondo e come approccio pastorale integrale e fecondo.